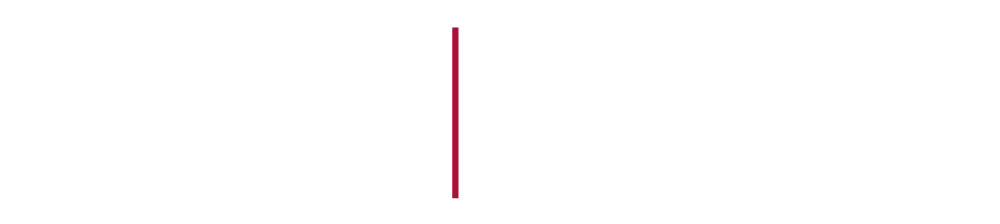L’articolo è pubblicato nella Rubrica “Diritti senza confini”, nata dalla collaborazione fra le Riviste Questione Giustizia e Diritto Immigrazione e Cittadinanza per rispondere all’esigenza di promuovere, con tempestività e in modo incisivo il dibattito giuridico sulle principali questioni inerenti al diritto degli stranieri. Vai alla Rubrica.
Il contributo commenta quattro recenti ordinanze di tre Tribunali di merito del Sud Italia in tema di contratto di convivenza tra cittadini italiani e cittadini stranieri in condizione di irregolarità nel soggiorno. I giudici sviluppano un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, e incentrata sulla tutela dei rapporti affettivi e familiari tra le persone, che riconosce che ai fini dell’iscrizione anagrafica, quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza, non è necessario il previo possesso di un valido permesso di soggiorno.
di Michela Spadaccino, Emma Zeppetella
studentesse della Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza dell’Università degli studi Roma Tre
Tribunale di Torre Annunziata, Sez. I Civ., ordinanza 11 novembre 2022
Tribunale di Torre Annunziata, Sez. I Civ., ordinanza 9 novembre 2022
Tribunale di Foggia, Sez. I Civ., ordinanza 30 novembre 2022
Il commento ha ad oggetto le ordinanze di quattro Tribunali di merito del Sud Italia in tema di tutela dei legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale tra cittadini italiani e cittadini di stati terzi in condizione di irregolarità nel soggiorno, regolati attraverso un contratto di convivenza, sottoscritto dall’avvocato di fiducia, in conformità alle previsioni della Legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà). Le prime tre ordinanze, che seguono ricorsi ex art. 700 c.p.c. nel caso dei Tribunali di Foggia e Torre Annunziata con riferimento al Comune di Sorrento, e art. 702-bis c.p.c. nel caso riguardante il Comune di Meta, affrontano la questione della registrazione del contratto di convivenza e, di conseguenza, l’inserimento del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno nel nucleo familiare e anagrafico del cittadino italiano convivente. All’origine delle ordinanze vi sono tre vicende sostanzialmente analoghe. Una coppia composta da un cittadino italiano e un cittadino straniero, sprovvisto di permesso di soggiorno, ha stipulato un contratto di convivenza autenticato dall’avvocato di fiducia. L’atto è stato trasmesso all’Ufficio Anagrafe del Comune ai fini dell’inserimento del cittadino straniero nei registri della popolazione residente e della contestuale iscrizione nello stato di famiglia del convivente, con annotazione del patto di convivenza. In tutti e tre i casi, il Comune ha opposto l’insussistenza delle condizioni necessarie alla registrazione dell’accordo, risultando mancante il requisito dell’iscrizione anagrafica del cittadino straniero, in quanto sfornito appunto di un valido permesso di soggiorno.
Diversamente, la quarta ordinanza, emessa dal Tribunale di Napoli, che segue un ricorso ex art. 700 c.p.c., vede convenuta la Questura locale per l’annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero convivente con il cittadino italiano. In questo caso, infatti, la Questura ha rigettato la domanda, nonostante il Comune avesse provveduto a registrare il contratto di convivenza, ritenendo che «alla registrazione del contratto di convivenza non può essere certamente riconosciuta il carattere di debita attestazione, dal momento che manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia»: per lo stesso motivo l’istante non poteva quindi essere considerato un componente della famiglia anagrafica. Tutte e quattro le ordinanze accolgono i ricorsi e ordinano alla P.A. di porre in essere gli atti richiesti ossia la registrazione anagrafica o l’annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Le ordinanze ruotano intorno all’applicazione della Legge n. 76/2016 che ha disciplinato, tra le altre cose, la convivenza di fatto, introducendo l’istituto del contratto di convivenza. In particolare, il comma 36 dell’articolo unico della legge n. 76 /2016 enuncia i due elementi costitutivi dell’istituto della convivenza di fatto, ossia una particolare intensità del vincolo affettivo caratterizzato da uno stabile legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale e materiale. In aggiunta si richiede l’assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Il comma successivo invece afferma che «per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13» del regolamento anagrafico. Inoltre, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4193 del 17 febbraio 2021, ha precisato con riferimento ad una convivenza more uxorio priva di contratto di convivenza registrato, che quest’ultima «per assumere rilevanza nella materia dell’immigrazione e, in particolare nella disciplina dell’espulsione e del permesso di soggiorno per coesione familiare, debba essere caratterizzata dal requisito della stabilità della relazione non solo nell’ambito del rapporto, ma anche nella sua percezione come tale all’esterno, presso cioè la comunità sociale in cui essa è inserita». Proprio quest’ultimo profilo può essere integrato con la stipulazione del contratto, la cui registrazione garantisce la pubblicità e l’ufficiosità dell’atto, manifestando la serietà dei conviventi di fatto di volersi considerare tali di fronte alla collettività1.
Il circolo vizioso tra l’iscrizione anagrafica e il permesso di soggiorno
In relazione all’applicazione della Legge n. 76/2016, la circolare del Ministero dell’Interno, richiamando il parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha affermato che: «[il]requisito della dichiarazione anagrafica previsto dal predetto comma 37 dell’art. l della Legge n. 76/2016, [è] posto dall’Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i soggetti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, a tutela di un interesse generale, quale quello della sicurezza e dell’ordine pubblico». Ed è proprio questa la motivazione alla base del rigetto della domanda di iscrizione anagrafica con annotazione del contratto di convivenza da parte dei Comuni di Foggia, Meta e Sorrento. Secondo i Comuni, la legge individua nell’iscrizione anagrafica il prerequisito naturale, nonché la condicio sine qua non, della possibilità di registrare i conviventi di fatto.
Tuttavia, i Comuni ritengono che, ai fini della stessa iscrizione anagrafica, è necessario che il cittadino straniero sia regolarmente soggiornante nel territorio. Al contempo, la Questura di Napoli, pur in presenza della registrazione del contratto di convivenza, ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari poiché lo straniero al momento della conclusione del contratto di convivenza non era regolare sul territorio nazionale.
Vi è quindi una discrasia che renderebbe a priori impossibile la regolarizzazione del cittadino straniero: da un lato il Comune ritiene che, per essere iscritto nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero debba ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno presso l’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente e, dall’altro, lo stesso Ufficio Immigrazione, in assenza di iscrizione anagrafica, nega il permesso di soggiorno, in questo caso, per motivi familiari ex art. 10 D.lgs. 30/20072.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito
Le ordinanze in questione si inseriscono nel solco tracciato dalla giurisprudenza precedente sia sul piano nazionale che comunitario. Il ragionamento sviluppato dai giudici può essere così sintetizzato.
Le ordinanze giungono all’approdo che la normativa relativa all’iscrizione anagrafica non richiede quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza e l’inserimento nel nucleo familiare del convivente italiano, il possesso di un permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero.
Per giungere a tale conclusione, i giudici hanno adottato una lettura combinata dell’art. 1 comma 52 della l. 76/2016 e degli artt. 3(co 2) e 9(co 5 bis) del d. lgs. 30/2007 (attuativo della Direttiva 2004/38/CE). In particolare, l’art. 3 comma 2 del d. lgs. 30/2007 recepisce l’obbligo in capo agli stati membri di agevolare l’ingresso nel loro territorio dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, ricomprendendo alla lettera b) la figura del “partner” considerata tale dalla Direttiva 2004/38/CE in virtù di una «relazione stabile debitamente attestata».
Per meglio delineare quest’ultimo profilo, il giudice di Torre Annunziata, nel caso di Sorrento, richiama la comunicazione COM 2009 (313) della Commissione Europea, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE, la quale riconosce che la prova della stabilità della relazione «può essere fornita con ogni mezzo idoneo».
L’art. 9 comma 5 bis del D. lgs. 30/2007, in materia di iscrizione anagrafica, prevede il requisito aggiuntivo per le persone ex art. 3 comma 2 lettera b) di fornire «documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione».
A sostegno di tale lettura i giudici, in particolare quelli di Torre Annunziata e di Napoli, richiamano la giurisprudenza nazionale e comunitaria. Segnatamente, l’ordinanza n. 3210 della Corte di Cassazione che ha stabilito la sostanziale irrilevanza della irregolarità del soggiorno in Italia ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La decisione di legittimità si basa sull’interpretazione vincolante della Direttiva 2004/38/CE fornita dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Metock3, in cui quest’ultima si è discostata dal proprio orientamento precedente. I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che dovesse essere riformulato il principio secondo il quale «per poter godere dei diritti di cui all’art. 10 del regolamento n. 1612/68, il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro quando il suo spostamento avviene verso un altro Stato membro, in cui il cittadino dell’Unione emigri o sia emigrato». In particolare, secondo l’interpretazione fornita dalla CGUE, la direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino straniero, familiare di un cittadino europeo che raggiunga o accompagni predetto cittadino, di ottenere un titolo di ingresso o soggiorno nello stato membro ospitante a prescindere dall’aver soggiornato regolarmente in un altro Stato membro4.
Questo cambio di rotta ha avuto conseguenze anche sul diritto nazionale sia in materia di matrimonio5, sia di convivenza di fatto. Rispetto a quest’ultimo profilo, si può ritenere che negare la richiesta di iscrizione anagrafica in mancanza di permesso di soggiorno significhi rendere di fatto impossibile l’effettiva coesione familiare del convivente, e quindi una violazione del diritto alla tutela della vita familiare e dei legami affettivi, nonché un ostacolo alla libertà di movimento e residenza dei cittadini comunitari6.
Coerentemente, la Cassazione ha dichiarato che una normativa interna che imponga al coniuge straniero del cittadino dell’Unione europea la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro è incompatibile con la Direttiva 2004/38/CE7.
Il giudice di Torre Annunziata, nel caso di Sorrento, evidenzia come la legislazione italiana richieda la «documentazione ufficiale» per la attestazione della convivenza, ma che di fatto questa si sostanzia nella disponibilità di un previo permesso di soggiorno. Ciò non garantisce l’effetto utile di garantire la libera circolazione, principio interpretativo espressamente richiamato dalla Corte di Giustizia nella decisione C-83/11, con riferimento al requisito posto all’art. 3 comma 2 d lgs 30/2007 per gli stati membri di agevolare l’ingresso nel loro territorio dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Analogamente, Il Tribunale di Napoli, ricollegandosi agli orientamenti della Cassazione8, ha affermato che il precedente soggiorno irregolare del cittadino straniero non deve essere di impedimento a priori al riconoscimento del diritto di soggiorno per motivi familiari. Questo risulta in linea con l’art. 8 CEDU, ed è inoltre coerente con un’interpretazione evolutiva del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui, alla luce dei principi costituzionali e unionali.
In conclusione, le ordinanze affermano che, in forza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, la disciplina italiana in materia non richiede espressamente la sussistenza del permesso di soggiorno quale presupposto per l’iscrizione anagrafica. In aggiunta, le ordinanze riconoscono la diretta applicabilità interna della Direttiva 2004/38/CE, da cui discende che sia la stabilità della relazione, sia il diritto all’iscrizione anagrafica sussistono indipendentemente dal possesso di un valido permesso di soggiorno.
In aggiunta, l’ordinanza di Foggia si interessa anche della problematica legata alla registrazione del contratto di convivenza e del ruolo giocato dall’iscrizione anagrafica prevista dall’art. 1 comma 37 della legge n. 76/2016. Il Tribunale prende atto delle due tesi circa la corretta interpretazione del comma 37 e la sua natura giuridica. Secondo una prima impostazione formalistica, la dichiarazione anagrafica ha valenza costitutiva; tuttavia, il Tribunale propende per un’interpretazione sostanzialistica per cui l’iscrizione anagrafica è da intendersi quale elemento di mero accertamento, a carattere presuntivo, della stabile convivenza. L’opinione prevalente in giurisprudenza è concorde nel ritenere che la dichiarazione anagrafica abbia un valore ricognitivo di una situazione in atto9, che può assurgere a strumento di prova privilegiata della convivenza di fatto, fermo restando che l’accertamento può essere reso con qualsiasi mezzo di prova. Secondo il giudice di Foggia, infatti, «diversamente opinando, dovrebbe ritenersi costituita, in presenza del requisito formale, la convivenza di fatto paradossalmente iniziata da un solo giorno». In conclusione, la mancanza della dichiarazione anagrafica non ostacola la configurabilità della convivenza di fatto, se vi sono altri indici presuntivi volti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza.
Le implicazioni future
Nonostante la decisione emessa dal singolo Tribunale abbia conseguenze dirette solo tra le parti in causa, è di fondamentale importanza che, al fine di una corretta interpretazione della legge, si tenga in considerazione il contenuto dei precedenti giurisprudenziali. Non fosse altro per favorire un’armonizzazione delle prassi amministrative comunali, evitando pratiche discriminatorie ai danni dei cittadini stranieri e differenze territoriali all’interno dello Stato. E ciò, a maggior ragione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 44182/2016, secondo cui «la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione». Infatti, una volta ammessa tale causa ostativa, la logica conseguenza non può che essere il rilascio di un titolo di soggiorno al cittadino straniero convivente con il partner italiano10.
I descritti sviluppi giurisprudenziali appaiono inoltre coerenti con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di tutela della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, l’insieme dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano contribuisce a dar forma al concetto di vita privata sancito dalla Convenzione11. La stessa evoluzione normativa in materia di immigrazione, con l’introduzione della fattispecie della protezione speciale all’art. 19, co. 1.1 del D.lgs. 286/1998, da parte del D.L. 130/2020, aveva dato rilevanza alla tutela della vita privata e familiare ai fini della maturazione di un diritto a rimanere sul territorio, indipendentemente dalla titolarità di un precedente permesso di soggiorno. La riforma dell’ottobre 2020, introduceva infatti tra le ipotesi di non espellibilità, la tutela della vita privata e familiare dello straniero, da cui discendeva il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale[enf_note]M. Ferri, La tutela della vita privata quale limite all’allontanamento: l’attuazione (e l’ampliamento) degli obblighi sovranazionali attraverso la nuova protezione speciale per l’integrazione sociale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fascicolo n. 2/2021.[/efn_note]. Tuttavia, il recente d.l. n. 20/2023, pubblicato il 10 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale, ha abrogato le disposizioni sopracitate eliminando così la protezione speciale dall’ordinamento italiano. Il nuovo assetto normativo rischia così di aprire un contrasto con gli obblighi sovranazionali che vincolano l’Italia e, in particolare, con la giurisprudenza CEDU, che esige un’attenta valutazione dei vincoli familiari dello straniero da parte delle autorità degli Stati contraenti. La riforma apre quindi scenari preoccupanti per quanto riguarda la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dei cittadini migranti, e di quelli italiani ad essi legati da rapporti affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale.
Note:
- P. Richter Mapelli Mozzi, Cittadino straniero, privo del permesso di soggiorno, e richiesta di iscrizione in anagrafe come convivente di fatto di cittadino regolarmente residente, in Lo Stato Civile Italiano, 2021.
- P. Richter Mapelli Mozzi, Ancora sull’iscrizione anagrafica del convivente di fatto, cittadino straniero privo del permesso di soggiorno, in Lo Stato Civile Italiano, 2021.
- Corte giust. Cee, 25.7.2008, C-127/08, Baheten Metock et al. c. Irlanda.
- A. Ianniello Saliceti, Riflessioni sulla sentenza Baheten Metock e altri, in Gli Stranieri: Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione, 2009, 6, 198-204.
- Come, ad esempio, testimonia la Sentenza della Corte Costituzionale 25.7.2011, n. 245 in cui dichiara l’illegittimità dell’art. 116 nella parte in cui preclude a contrarre matrimonio gli stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
- Trib. Bologna, 3.2.2020, r.g. n. 21280/2019.
- Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3210 del 09/02/2011.
- Sentenza Corte di Cassazione n. 12745/2013 e Sentenza Corte di Cassazione n. 5303/2014.
- Trib. Benevento, 19.1.2022, r.g. 4387/2021; Trib. Milano, 25.4.2021, r.g. 11914/2021; Trib. Modena, 7.2.2020, r.g. 370.
- P. Morozzo della Rocca, La convivenza di fatto e il diritto di soggiorno del partner straniero del cittadino italiano o europeo, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fascicolo n. 3/2022.
- M.P.E.V. and Others v. Switzerland, Application n. 3910/13, European Court of Human Rights, 8 July 2014.