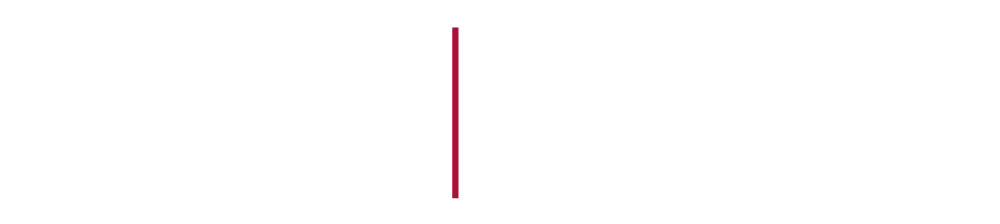Il decreto chiarisce cosa debba intendersi per “componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione” ma l’elenco della casistica determina risultati paradossali.
È arrivato il 13 dicembre scorso (con pubblicazione in GU il 16.12.2023) l’atteso decreto del Ministero del Lavoro che aveva il compito di colmare alcuni punti oscuri del DL 48/2023 in tema di Assegno di inclusione (ADI), cioè la misura “sostitutiva” del Rdc, entrata in vigore il 01.01.2024 (sulla base delle domande presentabili dal 18.12.2023).
Come noto, uno dei punti più oscuri della nuova disciplina era la aggiunta operata in sede di conversione in legge. Resosi conto che limitare la misura di contrasto alla povertà ai soli nuclei familiari con almeno un componente minorenne, o disabile, o anziano (con almeno 60 anni) avrebbe ristretto esageratamente la platea dei possibili beneficiari, il legislatore ha aggiunto la categoria dei “componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”: costoro (o i nuclei familiari cui appartengono) possono accedere alla misura anche se non hanno la condizione familiare sopra indicata (cioè, per esemplificare, se sono una coppia di quarantenni senza figli).
Restava tuttavia da individuare la portata effettiva della previsione, al fine di dare indicazioni ai soggetti “certificanti” nelle cui mani viene ora rimesso il diritto di acceso o meno all’ADI.
Ebbene il Ministero fornisce ora una minuziosa elencazione casistica che in primo luogo suscita perplessità per la pretesa di formare un elenco esaustivo dei beneficiari (non si vede perché i servizi sociali di un Comune non possano “prendere in carico” anche un soggetto che non rientra nella casistica indicata dal Ministero); ma soprattutto rende macroscopicamente evidente l’illogicità dei due requisiti che tante esclusioni determinano in danno degli stranieri: quello della pregressa residenza in Italia per almeno 5 anni (di cui gli ultimi due continuativi) e quelli relativi alla cittadinanza (essere italiano o europeo o familiare di europeo, o titolare del permesso di lungo periodo o dello status di protezione internazionale).
Basti a tal fine scorrere l’elenco contenuto nel DM: persone affette da disturbi mentali o con dipendenze patologiche, tra cui la dipendenza da alcol o gioco; persone vittime di tratta o di violenza di genere; ex detenuti nel primo anno successivo al fine pena; persone che “in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio” e siano pertanto inserite ai sensi della L. 328/2000 in strutture di accoglienza; persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, L. 1228/54 o persone “in condizione di povertà estrema e senza dimora” che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; giovani tra i 18 e i 21 anni che vivono fuori dalla famiglia in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria.
L’elencazione, oltre ad essere di dubbia legittimità nella parte in cui pretende di essere esaustiva (ovviamente un Comune potrebbe scegliere di prendere in carico anche persone fragili non rientranti nell’elenco) rende ancora più illegittimi i due requisiti sopra richiamati: da un lato perché, come detto, è irragionevole richiedere la pregressa residenza quinquennale a una persona (ad es.) “senza fissa dimora e in condizione di povertà estrema” che ovviamente dovrebbe essere aiutata in quanto tale e non in forza della durata della sua residenza; dall’altro perché alcune delle categorie indicate saranno evidentemente prive del permesso di soggiorno richiesto: ad es. una vittima di violenza domestica avrà probabilmente un permesso ex art. 18bis TU immigrazione e dunque non ha senso che riceva un aiuto pubblico solo se ha un permesso di lungo periodo.
Deve dunque riaprirsi la discussione sia sulla limitazione per permesso di soggiorno (che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima nella sentenza 19/2022 proprio valorizzando, per il Rdc, la funzione di inserimento al lavoro e non di contrasto alla povertà che in questi casi invece prevale) sia sui 5 anni di residenza, rispetto al quale si attendono le indicazioni che potranno arrivare dalle decisioni della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale relativamente al requisito di residenza decennale del Rdc.
Nel frattempo, sarà comunque necessario monitorare l’implementazione delle nuove misure relativamente all’esclusione delle persone straniere, contestandole anche in sede giudiziale.
Per un ulteriore approfondimento:
“Selezione” dei poveri e nuove discriminazioni nel D.M. del 13.12.2023 in tema di assegno di inclusione, di Alberto Guariso
Sulle analoghe questioni poste anche dalla prestazione del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) si veda il precedente articolo pubblicato su questo sito.
Immagine di Freepik