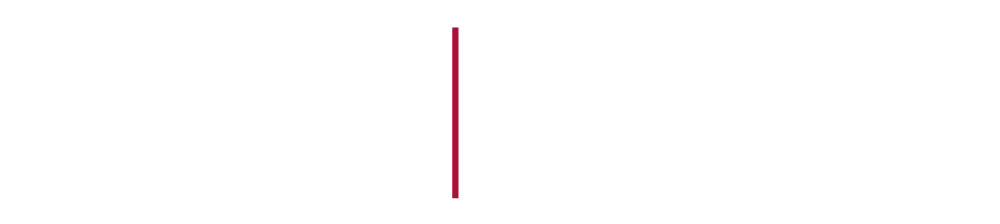Un’azione popolare promossa da due cittadini residenti in Puglia è l’occasione della recente e innovativa sentenza della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, con cui si affronta il delicato tema della detenzione amministrativa delle persone straniere, delle condizioni del trattenimento e delle ricadute, in termini di responsabilità dei singoli cittadini ed eventualmente di danno, sulla collettività.
di Dario Belluccio
avvocato del Foro di Bari
L’articolo è pubblicato nella Rubrica “Diritti senza confini”, nata dalla collaborazione fra le Riviste Questione Giustizia e Diritto Immigrazione e Cittadinanza per rispondere all’esigenza di promuovere, con tempestività e in modo incisivo il dibattito giuridico sulle principali questioni inerenti al diritto degli stranieri. Vai alla Rubrica.
Sentenza della Corte d’Appello di Bari del 30 novembre 2020, n. 2020
1. Il contesto
Con la sentenza n. 2020 del 30 novembre 2020 la prima sezione civile della Corte di Appello di Bari (Pres. M. Mitola, est. V. Gaeta) ha sostanzialmente confermato i principali assunti di merito contenuti nella precedente pronuncia del Tribunale del capoluogo pugliese n. 4089 del 10 agosto 2017 (est. C. Potito) e, dunque, condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per lesione della identità del Comune di Bari derivante dal trattamento inumano e degradante riservato ai cittadini stranieri trattenuti nel CPR di Bari.
Al fine di meglio comprendere gli esiti del giudizio è bene riassumere, sia pure molto brevemente, il complesso iter da cui origina.
Ad inizio del 2011 due avvocati e cittadini baresi promossero innanzi al Tribunale civile di Bari un procedimento di accertamento tecnico preventivo volto a valutare lo stato del Centro di identificazione ed espulsione di Bari (attualmente rinominato CPR) e, dunque, se i cittadini stranieri fossero ivi trattenuti in assenza delle necessarie garanzie a tutela della dignità personale. All’esito il CTU individuò diverse criticità e suggerì varie opere di adeguamento delle Linee guida per la progettazione dei CIE, redatte nel 2009 dagli uffici del Ministero dell’Interno. Al contempo, il perito escluse tuttavia la violazione dei diritti dei migranti trattenuti.
Instaurato il successivo giudizio a cognizione piena (nel cui ambito fu incardinato altresì un giudizio cautelare in corso di causa concluso con ordinanza oggetto di successivo procedimento ai sensi dell’art. 669-duodecies cpc), gli attori conclusero rilevando la intrinseca contraddittorietà dell’elaborato peritale e delle sue conclusioni; dunque, previo accertamento della non vincolatività delle linee guida ministeriali di cui sopra e della lesione degli standard minimi di trattenimento delle persone, chiesero la chiusura del centro e la condanna degli Enti convenuti a risarcire al Comune e alla Provincia sia il danno da violazione dei diritti umani all’interno del CIE, sia il danno subito quali enti esponenziali delle comunità ivi insediate.
La articolata sentenza di primo grado motivò ampiamente in ordine alla giurisdizione ordinaria ed alla legittimazione attiva degli attori popolari e concluse rigettando, per mancanza di interesse, la domanda volta alla chiusura della struttura che, nel mentre del giudizio, era stato temporaneamente chiuso a causa di una serie di proteste che ne avevano danneggiato la funzionalità1. Tuttavia, rilevando che il centro non garantisse né l’assistenza né la dignità degli stranieri ivi trattenuti coercitivamente, i quali anzi erano stati sottoposti a trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 Convenzione EDU, e che il Comune e la Provincia di Bari avessero subito un danno d’immagine dalla sua collocazione (da loro non scelta ed, anzi, formalmente contestata dallo stesso Comune di Bari anni addietro2), condannò Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo risarcimento del danno3.
Oggetto del giudizio della Corte di Appello di Bari è stata tale decisione, pur se esclusivamente nella parte effettivamente impugnata: in secondo grado, infatti, alcuni dei temi di lite si erano erosi non essendo stati oggetto di impugnazione e, tra questi, innanzitutto quelli attinenti la giurisdizione ordinaria a decidere e la legittimazione attiva degli attori popolari.
All’esito di articolata motivazione, la Corte di merito, esclusa la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la condanna al risarcimento del danno della Città metropolitana di Bari (nel mentre subentrata alla soppressa Provincia) e pur riducendo il quantum della condanna, ha nel resto di fatto confermato la pronuncia di prima grado.
2. L’azione popolare come strumento di controllo democratico
Particolare interesse, in chi scrive, ha sempre suscitato l’utilizzo dello strumento processuale di cui all’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in base al quale «Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia». Si tratta di uno strumento eccezionalmente suppletivo o sostitutivo fornito al cittadino elettore (con ciò dovendosi intendere residente e titolare di diritto di voto nell’ambito territoriale) che presuppone, da un lato, la astratta legittimazione attiva dell’Ente locale nel fare valere un proprio diritto o interesse e, in secondo luogo, l’inerzia dello stesso Ente locale, la quale “apre la strada” alla richiesta di tutela in sua vece da parte del singolo cittadino.
Questo istituto non può dirsi recente: l’actio popularis risale addirittura al diritto romano e nell’ambito della legislazione nazionale una simile ipotesi si rinviene già nell’art. 114 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1889 (R.D. 10 febbraio 1889, n. 5921), poi abrogato durante il fascismo e tornato in vigore con la reviviscenza, operata dall’art. 23, l. 9 giugno 1947, n. 530, dell’art. 225 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (T.U. della legge comunale e provinciale). La norma stabiliva che «Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l’autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune». Formulazione evidentemente indigesta alla Costituzione repubblicana, tanto da essere oggetto, con la sentenza n. 103 del 7 maggio 1975 della Corte costituzionale, di dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di trattamento tra i cittadini, nella parte in cui limitava lo jus actionis al “contribuente” e non al cittadino.
Più simile a quella vigente è la prosa del legislatore del 1990, con l’art. 7 della legge n. 142, poi oggetto di rivisitazione da parte dell’art. 4, l. n. 265 del 3 agosto 1999, poi abrogato proprio dal d.lgs. n. 267/2000.
Si tratta di una evidente ipotesi di sostituzione processuale che trova spazio, in deroga all’art. 100 cpc, nella lettura dell’art. 81 cpc («Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui») attraverso una chiara tipizzazione dell’ambito di specialità normativa prevista dal codice di rito.
Sul presupposto dell’inerzia del soggetto legittimato attivo in via principale, si fa valere in giudizio, in nome proprio, un diritto formalmente altrui, pur senza mai prospettarlo come direttamente proprio.
Va dunque dato atto agli attori di avere utilizzato lo strumento dell’actio popularis in modo efficace, oltre che corretto, ancorché la titolarità della posizione giuridica sostanziale fosse indubbiamente in capo all’Ente locale. Evidentemente, in fattispecie, l’azione popolare non contrastava (né avrebbe potuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina4) con la volontà dell’Ente locale sostituito, tanto è vero che Comune di Bari e Provincia/Città metropolitana di Bari sono intervenuti in giudizio aderendo alle conclusioni degli attori popolari.
Ma ancor più va apprezzato il pieno sviluppo che discende da questo “esperimento processuale”: è indubbio che l’azione popolare sia già ampiamente entrata nelle aule di giustizia (differentemente non avrebbe trovato ripetuto spazio nella legislazione contemporanea). Ma, da quanto risulta a chi scrive, gli ambiti tematici prediletti (sia pur non esclusivi) della stessa sono stati quelli della valorizzazione del territorio e della tutela dell’ambiente. Ora, probabilmente per la prima volta, viene in realtà utilizzato per fare valere, attraverso il diritto immediato del soggetto sostituito dall’attore popolare, il diritto (invisibile) del migrante recluso. Fornendo, in questo modo, un utilissimo strumento di controllo democratico che si affianca a quelli più immediatamente “conoscitivi” esperibili, ad esempio, attraverso gli istituti dell’accesso agli atti e dell’accesso civico generalizzato.
Ma, soprattutto, promuovendo attuazione di un principio fondamentale del vivere associato, ovvero il principio di responsabilità quale portato di quello di solidarietà sociale nei confronti di chi quello strumento non può certamente utilizzarlo (interessante sarebbe, sotto tale punto di vista e soprattutto considerata la sostanziale inerzia del parlamento nel mettere mano alla riforma della legislazione sulla cittadinanza, tornare a parlare del diritto di voto locale dei cittadini extracomunitari, riprendere ad esempio il ddl costituzionale n. 516/2006 e quindi nuovamente ragionare della riforma dell’art. 48 Cost.).
Questione, invero, ben presente al giudice dell’appello il quale (pur non potendo entrare nella questione della legittimazione attiva degli attori in primo grado, in quanto la questione non era più oggetto di contesa) coglie, tra gli altri, uno degli aspetti più rilevanti della vicenda quando afferma che «Un cittadino elettore (di Bari, nella specie) può non sentirsi indifferente al fatto che nella sua città sia localizzato un Centro come quello in esame, dove è tenuta in così scarsa considerazione la dignità delle persone ospitate»5.
Ma se il fine del controllo democratico può dirsi consustanziale all’azione popolare, in questo caso esso vede esplodere le proprie potenzialità incidendo concretamente sugli interessi e sui diritti dei nuovi “dannati della terra”, dando voce collettiva a chi difficilmente riesce ad esprimerla, guardando ai centri di detenzione amministrativa delle persone straniere non come strumento esclusivamente coercitivo delle libertà dei singoli, ma come aporia della democrazia tutta, rendendogli concretezza in quanto epifenomeno del più complesso sistema di gestione delle migrazioni al tempo moderno.
In questo senso l’actio popularis va ad arricchire lo strumentario a disposizione di coloro che, pur facendo uso del diritto e del processo, vedono nella tutela dei diritti delle persone straniere la tutela dei diritti fondamentali della persona tout court, rende “responsabile” e quindi attivo socialmente e giuridicamente il cittadino di fronte alla violazione di diritti fondamentali dell’individuo.
3. Il motore del giudizio
Ma il cittadino straniero, il recluso, il trattenuto non è spettatore passivo di questo processo. Anzi, possiamo con sicurezza affermare che colui che pare essere esclusivamente oggetto di una iniziativa formalmente altrui, colui che non è legittimato a proporre quell’azione popolare (in quanto non residente e tampoco elettore), che non è direttamente interessato dagli esiti del giudizio6 (ma ciò solo in quanto le pronunce di primo e di secondo grado hanno dichiarato una mancanza di interesse in tale senso degli attori, che pur hanno “sfiorato” il risultato della chiusura del CPR di Bari), è forse il primo motore dell’azione.
La sentenza della Corte di Appello di Bari è tale da fare emergere la voce ed il reale protagonismo delle persone straniere trattenute nel centro di detenzione amministrativa. Protagonismo che si esprime nelle forme loro consentite o, meglio, nelle (forse) uniche forme atte a fare emergere la voce di chi si vuole, all’interno di un sistema di fatto impermeabile all’osservazione indipendente dall’esterno, fare rimanere silente; nelle forme idonee a restituire dignità alla persona che si trova in una condizione “disumana e degradante”: proteste, atti di autolesionismo, rivolte, scioperi della fame.
Già in primo grado, invero, il Tribunale sottolineava che le numerose rivolte e proteste delle persone trattenute nel CIE/CPR erano da considerarsi indice di oggettiva intollerabilità della permanenza nella struttura e non andavano sminuite quale mera insofferenza alla condizione carceraria.
Il giudice del Collegio si sofferma più volte, sia nella parte ricostruttiva sia in quella motivazionale sulla rilevanza dell’iniziativa dell’invisibile per eccellenza nella società nostrana, ovvero il sans papiers, lo straniero irregolare: «Prima dell’iniziativa degli attori popolari, in particolare, l’unico mezzo di interlocuzione con l’autorità a disposizione degli stranieri era dato da forme di protesta a rischio o di violenza o di autolesionismo….al di là delle numerose rivolte con danni alle cose, i 59 scioperi della fame del solo 2012 costituiscono un dato autoevidente e non minimizzabile»7; «Né la mera “insofferenza al regime di controllo” né il “desiderio di scappare” indicati dagli appellanti [l’Avvocatura distrettuale dello Stato, Ndr] potevano quindi spiegare le ripetute proteste, con violenza sulle cose o con messa in pericolo della propria salute mediante digiuno. Quella insofferenza e quel desiderio ben possono essere comuni ai carcerati, che tuttavia nonostante la caratura criminale solo a volte attuano tali proteste. Una persona detenuta, infatti, ha comunque una sua identità: sa o può sapere dove si trova, per quale ragione (colpevole o innocente che sia), per quanto tempo (la pena inflitta o i termini di custodia cautelare), con quali diritti e con quali doveri, e ha la possibilità non solo di svolgere le attività sopra indicate ma anche di cure mediche, assistenza religiosa, visite di parlamentari e volontari, e infine di una qualche solidarietà, non necessariamente criminale, con i/le compagni/e di sventura»8; «I problemi di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla presenza di un Centro così mal gestito non possono certamente essere sottovalutati, se solo si considerano le numerose proteste degli ospiti, non violente o con violenza sulle cose che fossero»9; «Un cittadino elettore (di Bari, nella specie) può non sentirsi indifferente al fatto che nella sua città sia localizzato un Centro come quello in esame, dove è tenuta in così scarsa considerazione la dignità delle persone ospitate, e dove si verificano continue rivolte e proteste, frutto di impotenza ad agire ben più che di effettiva e preesistente aggressività»10.
La sentenza della Corte di Appello di Bari, come anche quella precedente del giudice monocratico, non presta il fianco a letture ideologiche e, anzi, si pone nell’ottica fatta propria dalla dialettica processuale che «pur vertendo sul delicatissimo e mai totalmente risolvibile conflitto tra la libertà di circolazione delle persone straniere e la regolamentazione dei flussi migratori da parte dell’autorità, si è sviluppata secondo toni di assoluta civiltà e razionalità, sia nelle argomentazioni strettamente giuridiche che in quelle più fattuali o socio-politiche».
Se non era scontato che tale difficile crinale fosse affrontato dalle parti con la dignità e la serietà che dovrebbero sempre caratterizzare la discussione giudiziaria (ciò di cui da atto la magistratura barese), altrettanto non era scontato decidere su una vicenda impregnata di «fortissima emozionalità» con la dovizia motivazionale, l’attenzione giuridica e la mancanza di retorica che certamente emergono dalla sentenza.
Ne abbiamo conferma nella lettura delle interessanti pagine dedicate alla declinazione del concetto di identità territoriale e della sua valenza e ricaduta giuridica11, che portano alle conclusioni della sentenza in termini di condanna in favore del Comune di Bari e, contestualmente, di rigetto della domanda proposta in favore della Città metropolitana di Bari.
Sembra a chi scrive che ciò non sia contraddetto da quello che emerge quale un dato di fatto acquisito dal processo: la “voce” del cittadino straniero trattenuto in un centro di detenzione amministrativa, la sua azione politica, non solo è fuoriuscita dalle mura del recinto fisico costruito dall’amministrazione, ma si è fatta anche “diritto” trovando “giustizia”: quella parola, espressa in variegata protesta (a volte pacifica, a volte violenta, troppo spesso autolesionistica), è uno degli indici che, tanto il magistrato di primo grado quanto il collegio di secondo grado, devono tenere presente e necessariamente assumono quale riferimento per potere giungere alla decisione.
Volendo utilizzare il neologismo fatto proprio dal giudice d’appello – che cita l’etnologo Marc Augé12 – possiamo senza eccessiva audacia affermare che l’azione popolare promossa dai cittadini Alessio Carlucci e Luigi Paccione (entrambi avvocati) ha costituito una delle estensioni nelle aule giudiziarie della voce delle persone straniere; protesi che ha trovato collocazione nelle molto motivate sentenze che, forse non solo per qualche singolo momento ma in maniera significativa e non puramente simbolica, hanno fatto emergere che il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari da “Non luogo” può trasformarsi in ambiente vivo, fatto di persone e corpi irriducibili a “nuda vita”, di dignità talvolta dolente ma difficilmente silente.
Photo by Jack Dong on Unsplash
Note:
- Su tale specifico punto ritiene non convincente la pronuncia di primo grado A. Giliberto, La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un C.I.E. (oggi C.P.R.) danneggia l’immagine della comunità territoriale dove la violazione è avvenuta, in Diritto Penale Contemporaneo, 21.12.2017, fascicolo 12/2017. L’A. Ritiene che «ben avrebbe potuto il Tribunale ordinare in via definitiva nel merito gli interventi strutturali peraltro già imposti in fase cautelare, con ciò non solo rispondendo alla legittima domanda di tutela proposta dagli attori, ma cogliendo altresì l’occasione per restituire alla giurisdizione ordinaria quella funzione di sorveglianza e tutela del rispetto dei diritti umani lungamente argomentata nei precedenti passaggi della motivazione».
- Il Consiglio comunale di Bari, nel 2004 (poco prima dell’apertura del centro di detenzione amministrativa nella città), sulla base del proprio statuto e richiamando i principi di solidarietà, tutela dei diritti umani e della pace tra i popoli, aveva formalmente espresso «la netta contrarietà di questa Comunità e della sua Amministrazione di ospitare un centro di permanenza temporanea sul proprio territorio, indipendentemente da qualsiasi tipo di gestione dello stesso». La delibera comunale.
- Per un altro commento alla sentenza n. 4089/2017 del Tribunale di Bari si veda anche F. Cortese, Se un Cie non funziona bene, l’immagine della comunità locale è danneggiata…, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fascicolo on line 1/2018.
- Cfr. C. Napoli, L’azione popolare, in A. Pertici (a cura di), Le autonomie locali nella giurisprudenza. Antologia di casi, pagg. 209 e ss,, Pisa University Press, 2012.
- Così la sentenza, pag. 14.
- Il Tribunale, confermato in questo dalla Corte di Appello, aveva affermato che il risarcimento del danno delle persone trattenute non poteva conseguire dalla domanda in quanto, benché ognuno dei trattenuti fosse stato indubbiamente leso, essi dovrebbero agire autonomamente in giudizio per ottenere il dovuto ristoro. Al contempo, il Tribunale è consapevole che tale possibilità è «abbastanza rara, in quanto tali soggetti versano in un’evidente situazione di “minorata difesa”, della quale non si può che prendere atto» (così pag. 27 della sentenza di primo grado).
- Così la sentenza, pag. 10.
- Così la sentenza, pag. 12.
- Così la sentenza, pag. 13.
- Così la sentenza, pag. 14.
- Cfr. pagg. 16 e ss. della sentenza.
- M. Augé, Non luoghi, Elèuthera, 2008.