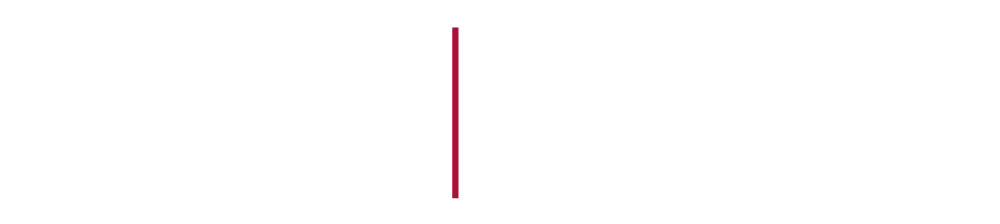E’ stata pubblicata sulla GU N. 82/2021 la L.46/2021 che conferisce delega al Governo per l’istituzione dell’assegno unico universale volto a unificare e semplificare le misure di sostegno alla genitorialità. Ma per quanto riguarda l’accesso degli stranieri ancora molte cose non vanno, anche per le incoerenze con il nuovo testo dell’art. 41 TU immigrazione che nel frattempo sta per essere varato.
L’assegno unico universale dovrebbe entrare in vigore, sotto forma di pagamento di un importo mensile o di credito d’imposta, dal 1.7.2021 (ma la data effettiva dipenderà dai decreti attuativi). Verrà riconosciuto sia ai lavoratori subordinati, sia ai lavoratori autonomi (questa l’innovazione principale) , sia ai titolari di prestazioni di sostegno al reddito (NASPI, reddito di cittadinanza ecc.):
L’assegno sostituirà in una prima fase tre prestazioni (assegno per le famiglie con almeno 3 figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita di 800 euro una tantum) e in una seconda fase anche le detrazioni fiscali per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare (la sostituzione sarà graduale).
Per quanto riguarda i requisiti di accesso la norma sembra voler porre fine (per il futuro) al contenzioso che riguarda le tre prestazioni sopra richiamate, ma apre ulteriori problemi. Sono infatti previsti i seguenti requisiti, che devono sussistere cumulativamente:
- Quanto alla cittadinanza, possono accedere all’assegno, oltre ai cittadini italiani e UE, i cittadini extra UE titolari di un permesso di lungo periodo, i titolari di un permesso “per motivi di lavoro o di ricerca” di durata almeno annuale. Non si comprende perché vengano enunciati solo due tipi di permesso (uno dei quali ha numeri modestissimi) trascurandone altri ben più rilevanti che pure possono avere durata annuale, e in particolare il permesso unico lavoro per motivi familiari o il permesso per protezione internazionale o nazionale: è ben vero che l’assegno potrà essere richiesto da uno dei due genitori (e dunque è presumibile che uno dei due abbia un permesso per lavoro) ma può ben accadere che la famiglia sia composta da soli titolari di permesso per famiglia (si pensi al caso di un unico genitore, vedovo o separato ) o per protezione. Stando alla lettera delle legge questi casi sarebbero esclusi. Inoltre, è inspiegabile il motivo per cui la norma non faccia più semplicemente riferimento al permesso unico lavoro, in coerenza con la direttiva 2011/98.
- Il beneficiario deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia e deve essere “residente e domiciliato con i figli a carico in Italia” (previsione che non sembra risolvere con certezza la questione posta dal contenzioso in materia di ANF, posto che un figlio può essere “a carico” anche se residente all’estero: dipenderà dalle previsioni dei decreti attuativi)
- Il beneficiario deve essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi “ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”: la previsione contraddice la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di illegittimità di requisiti di residenza pregressa in quanto del tutto estranei alla considerazione del bisogno, ma quantomeno prende in considerazione anche l’indice di “radicamento territoriale” costituito dal rapporto di lavoro: tale correttivo consentirà di ridurre molto gli effetti discriminatori del requisito biennale, ma escluderà dalla prestazione “universale” un’ area significativa di cittadini stranieri, cioè quelli che hanno fatto ingresso in Italia da meno di due anni e lavorano, come frequentemente accade, con contratti di lavoro a termine, che non sono mai di durata biennale.
- E’ poi previsto che “a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti”, una Commissione nazionale, istituita con decreto del Ministero per il lavoro, possa concedere, su proposta dei servizi sociali, specifiche deroghe ai requisiti di cui sopra: una previsione che introduce una apprezzabile forma di flessibilità, ma resta del tutto oscuro come possa una commissione nazionale esaminare singoli casi particolari e adottare provvedimenti tempestivi.
L’aspetto più problematico della innovazione sta tuttavia nel mancato coordinamento con la legge europea 2019-2020, ormai in corso di approvazione definitiva dai due rami del parlamento.
La legge prevede una modifica dell’art. 41 TU immigrazione nei seguenti termini:
- Per la generalità delle “provvidenze e prestazioni prestazioni di assistenza sociale” e per i titolari di permessi diversi dal permesso unico lavoro (e dunque per casi che sembrerebbero essere residuali) resta la regola della piena equiparazione a condizione che, come già ora, il permesso abbia durata di almeno un anno.
- Per le prestazioni che costituiscono diritti (cioè quelle erogate senza valutazione discrezionale ) e che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 883/04 CE (si veda l’elenco all’art. 3 del Regolamento) la parità di trattamento con i cittadini italiani è prevista solo per chi abbia svolto una attività lavorativa per periodi non inferiore a 6 mesi (si suppone, anche non continuativi) e abbia reso al Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (comma 1 bis)
- In deroga al punto b), per le sole prestazioni familiari, la parificazione è più ampia e trova applicazione a coloro che hanno un permesso che autorizzi lo svolgimento di attività lavorativa per periodi superiori a 6 mesi: in questo caso si guarda cioè al titolo di soggiorno e non alla attività concretamente svolta (comma 1 ter).
Così intervenendo, lo Stato italiano si avvale quindi di tutte le facoltà di deroga previste dalla direttiva 2011/98 che in effetti consente questo tipo di restrizioni rispetto alla generale parificazione (con gli italiani) di tutti i titolari di permesso unico lavoro. Ma poiché “l’assegno unico universale” è certamente una prestazione familiare, si avrà che in forza della L. 46/2021 il requisito è quello del “permesso per lavoro e ricerca di almeno un anno” e in forza della legge europea è invece quello del permesso che autorizza al lavoro per periodi superiori ai 6 mesi: in altre parole la legge europea prevederebbe un diritto più ampio di quanto faccia la legge sull’assegno unico appena votata.
Non solo: la legge europea prosegue modificando le singole norme regolative dell’assegno famiglie numerose, dell’indennità di maternità di base e dell’assegno di natalità: per detti istituti, in coerenza con la modifica dell’art. 41 cit., il requisito non è più, come ora, quello del permesso di lungo periodo (come noto, sempre dichiarato dai giudici illegittimo per contrasto con la direttiva 98) ma quello del permesso di cui ai commi 1-ter. Poiché si tratta proprio dei tre istituti che verranno assorbiti nell’assegno unico universale, la rapida successione delle due innovazioni determinerebbe esiti incoerenti e assolutamente inspiegabili: ad esempio il lavoratore che faccia ingresso in Italia con un permesso per lavoro ottenuto in relazione a un contratto a tempo determinato di 10 mesi (ipotesi non frequente, ma certamente consentita dall’art. 5, comma 3bis, TU immigrazione) avrebbe accesso all’assegno di natalità secondo la legge europea (avrebbe infatti un permesso che lo autorizza al lavoro per piu di 6 mesi) ma non avrebbe accesso al nuovo assegno unico secondo la L. 46/21 (non avrebbe né la residenza biennale, né un rapporto a tempo indeterminato, né un contratto a tempo determinato biennale).
E ancora la stessa modifica del primo comma dell’art. 41, come formulata, dà luogo a incoerenze perché il titolare di un permesso di almeno un anno “diverso dal permesso unico lavoro” (come recita il nuovo primo comma) si trova ad avere una parificazione completa, mentre il titolare del permesso unico lavoro, in forza della applicazione delle deroghe restrittive di cui ai commi 1bis e 1ter, viene parificato, per le prestazioni non familiari, solo in presenza di un lavoro effettivo di almeno 6 mesi: ciò in evidente contrasto con la ratio del diritto UE che evidentemente intende garantire ai titolari di permesso unico lavoro una tutela più ampia.
C’è solo da sperare che nei prossimi passaggi regolativi (da un lato i decreti attuativi della L. 46, dall’altro eventuali aggiustamenti dell’ultima ora della legge europea) riescano a riordinare la materia eliminando gli ostacoli alla parità di trattamento che i testi attuali ancora mantengono.
A cura di Alberto Guariso, servizio antidiscriminazione ASGI
Foto da Unsplash